a quarant’anni
(Michael Cunningham Al limite della notte)
Tempo di lettura: 2 minuti
Michael Cunningham, Al limite della notte (Bompiani, 2010, € 16,50, sarà nelle librerie il 20 ottobre, in contemporanea con l’America; la copertina italiana non è ancora disponibile). Dovevo leggerlo al volo e recensirlo sul giornale; salterò un po’ di pagine, pensavo, mi basta capire il senso; invece ho letto ogni parola, sottolineato, piegato angoli e a tratti riletto. Mi ha catturata dalla prima riga: «L’Errore sta venendo per fermarsi un po’». All’ottava capisci che l’Errore è una persona e dopo tre pagine sai che è il fratello minore di Rebecca la quale, su un taxi diretta a una festa, conversa col marito Peter. Lei è editor, lui un gallerista ben inserito nell’incerto mondo dell’arte contemporanea, sono una coppia di quarantenni a New York, ma potrebbero essere qui, sono come noi. Da abile narratore, Cunningham svela con i tempi giusti ogni dettaglio: come si sono conosciuti, le famiglie da cui provengono, il punto a cui sono arrivati insieme, il difficile rapporto con la figlia. Tornati dalla festa, Peter accende la tv, vedono un po’ di un film di Hitckock ma non il finale che già conoscono, poi vanno a letto, «Per lei sarebbe lo stesso se si mettessero semplicemente a dormire?» si chiede Peter, consumano con consolidata abilità un po’ di sesso di routine, «stanno per venire entrambi, manca poco, poi potranno dormire, e poi sarà domenica». Ma non è una domenica come le altre: Erry, il fratellino 23enne con un passato da tossico, arriva in casa con la sua spaventosa somiglianza con Rebecca da giovane, Peter ne è attratto per questo, e ne è attratto anche perché Erry risveglia in lui echi del rapporto con suo fratello Matthew, morto anni prima, e soprattutto ne è attratto perché vede in Erry talenti inespressi, un’inquietudine non sopita e intuisce per lui un destino tragico: e tutto questo “viluppo umano”, per Peter, è la bellezza. L’infatuazione di Peter non è strana, ma forse per capirla davvero bisogna avere quarant’anni. Perché è di questo che parla il romanzo, dell’età di mezzo, quel pianoro in cui si finisce per ristagnare dopo la salita dei venti e dei trenta, raggiunti gli studi, la famiglia, la carriera, quando il paesaggio della vita sembra un’inesorabile distesa piatta senza sorprese. Lo è per tutti. Infatti Peter, nelle ultime pagine, scopre che anche Rebecca vorrebbe cambiare, vorrebbe che succedesse qualcosa, ed è stanca di loro due. E come finale l’autore sceglie quello che alcuni troveranno rinunciatario e altri inevitabile. «Hanno fatto troppa strada insieme. Hanno tentato e fallito, tentato e fallito e probabilmente, in ultima analisi, non resta loro altro da fare che tentare ancora».
Post letto 1409 volte
Tags: 40, Al limite della notte, amore, arte, Bompiani, citazione, Michael Cunningham, quarantenni

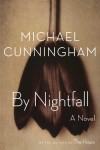

[…] questo articolo quattro anni fa. L'ho ripescato ora, dopo aver letto il romanzo sui quarantenni di Michael Cunningham. Trentenni e quarantenni esprimono, come ogni categoria generazionale, tratti sintetici e […]
[…] a quarant'anni (Michael Cunningham Al limite della notte) (72) […]
[…] a quarant'anni (Michael Cunningham Al limite della notte) (81) […]
Mi è piaciuto, soprattutto per come sa descrivere il rapporto tra marito e moglie, quel rapporto intimo di comunione d’intenti e di corrispondenza mentale però si è appesantito negli anni, non riuscendo a trascinare con sè i desideri, che vanno per la loro strada. Devo ammettere che ho amato di più “Le ore” e “Carne e sangue”, però Cunningham è sempre Cunningham, e io lo adoro
C’è una scena, alla fine di un capitolo, in cui prima di dormire è come se sentissero di dovere un po’ di sesso uno all’altra, ma non è che proprio lo desiderino… Magistrale! Cunningham è maestro di dettagli relazionali
Ero partito con un certo scetticismo: il retro di copertina ti fa capire che è la storia di un etero che si innamora di un uomo. Il tipico sogno del gay che si è innamorato del compagno di banco macho e ha sempre sperato che questo ricevesse l’illuminazione sulla via di damasco e cadesse nelle sue braccia…
Chi ha scritto il risvolto di copertina non ha capito lo spirito del libro, per nulla.
Se una storia è solida tanto più è universalizzabile, questaèé in odore di santità. Il concetto è: a tutti noi uomini e donne del ceto medio, di medio successo e con vita solida e cresciuti nella culla del sogno americano (tema ricorrente per Cunningham: geniale il retro di copertina di Carne e sangue che dice qualcosa tipo: “di quanta carne e quanto sangue è cosparso il sogno americano?”. By the way, libro bellissimo), può succedere di prendere una sbandata per una persona (o una cosa, o un hobby) totalmente al di fuori dei nostri interessi, e anche dei nostri gusti? Una cosa totalmente irrazionale, quella fiammata di passione che ti fa sentire vivo (di nuovo) ma che è destinata a spegnersi nel tempo di combustione dello zolfo su un fiammifero. Lo sai, ma bruci lo stesso. Potrebbe succedere? Sicuramente si, e a tutti noi é successo più o meno, e come ci siamo comportati o come ci comporteremmo in quel caso?
È questa la forza del romanzo. Far innamorare il protagonista di un uomo, con cui fra l’altro lui non condivide nulla e anzi lo disprezza dal punto di vista umano, è il mezzo per sottolineare la irrazionalità della cosa, l’assurdità della passione, che ciò nonostante cresce come un cancro nel cervello (geniale la conoscente malata di cancro, che da al protagonista una grande possibilità).
Certo, qualcuno si fermerà al primo livello di lettura, ma chi ha più profondità di un foglio di carta, potrà trarne qualcosa.
Come dicevo, Carne e sangue mi era piaciuto tantissimo: estremamente catartico e stimola il contrappasso. Quando lo leggi, non puoi che fare tutti i migliori propositi di non essere meschino gratuitamente e di comportarti bene coi famigliari.
Una casa alla fine del mondo, invece, l’ho trovato terribilmente noioso.